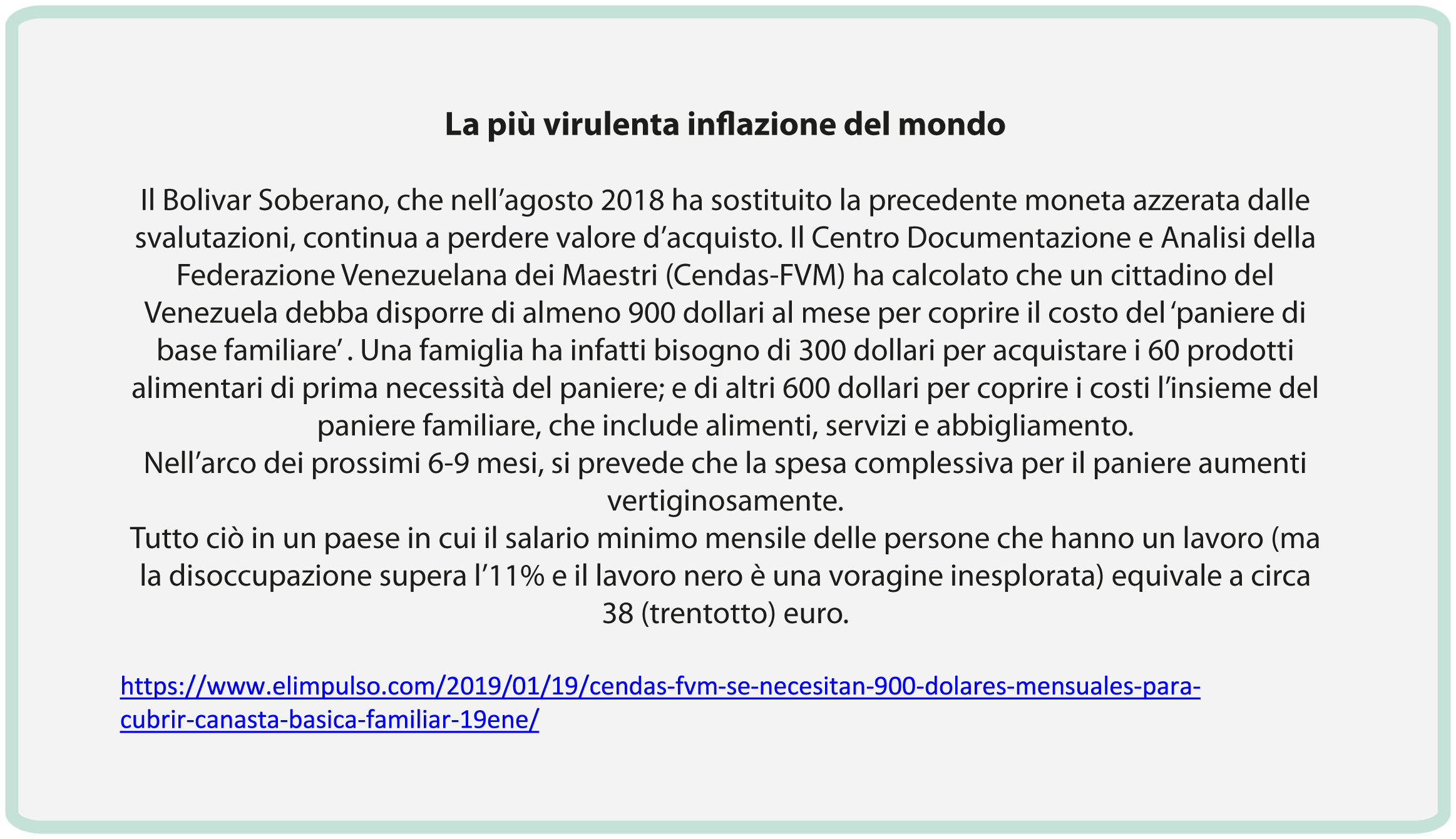Da mito a dramma, le cronache dell’attualità venezuelana raccontano un popolo diviso che si scontra nelle strade, morti, economia stagnante e un’inflazione al galoppo, da quegli stessi luoghi un tempo paradiso di corsari, cercatori d’oro, amanti dell’utopia e dell’avventura. Il Venezuela felix, che giusto cent’anni fa scopriva una nuova e immensa ricchezza nei torrenti di petrolio e gas che percorrono le sue viscere dal lago di Maracaibo al bacino dell’Orinoco, vive oggi nell’ansia e nella penuria più cupe. Ai sui 33 milioni di abitanti scarseggiano cibo e medicinali, lavoro e salute, ogni possibile sicurezza: l’indomani è incerto quanto l’oggi angoscioso. Può sembrare una parabola biblica sulla vacuità delle ricchezze materiali nel mondo degli uomini; è invece una storia dei nostri tempi, del tutto spiegabile; ma anch’essa non priva di morale.
Il grande paese sudamericano è affacciato sull’orrido della guerra civile. Non è la prima volta, ma questa potrebbe essere ancor più fatale delle precedenti. C’è un governo autoritario che rivendica di aver migliorato le arretratissime condizioni di vita di metà della popolazione, quella sperduta tra il mare, le montagne e le caotiche periferie delle città. Il suo presidente si chiama Nicolàs Maduro, un uomo imponente e risoluto. Avrebbe voluto fare il soldato, è diventato il comandante in capo di tutti i suoi, finché gli obbediranno. Ha ereditato il potere dal predecessore, Hugo Chavez, un capitano dei paracadutisti con spiccata vocazione al comando, eletto da una sostanziosa maggioranza nel 1999 e morto prematuramente di cancro nel 2013. Maduro era il suo uomo di fiducia. Ora si sostiene principalmente grazie ai militari, ai quali tanto più la situazione si fa difficile quanti maggiori benefici concede.
Si dichiara socialista bolivariano, ma niente a che vedere con Lenin, meno ancora con Turati. I più lo chiamano populista. Bolivariano (dal glorioso libertador Simon Bolivar) va incontro al patriottismo, specialmente vibrante nei paesi che non si sentono compiutamente sovrani e indipendenti. Semantica e politica non sempre vanno d’accordo. In questo caso, si tratta di un populismo di sinistra: è un regime a vocazione sociale, contrario al capitalismo, estraneo ai diritti e alle libertà come sono concepiti nei sistemi liberali. Per intenderci: almeno in teoria quelli di quasi tutto l’Occidente. Purtroppo, nominalismi a parte, il chavismo – come pure viene definita questa esperienza venezuelana – ha senza dubbio migliorato la qualità della vita di tanti cittadini mantenuti fino a qualche decennio addietro in condizioni semi-feudali; ma senza potenziare la produttività e al prezzo di compromettere l’esistenza dell’intero paese.
Nondimeno la responsabilità del fallimento non può essere scaricata del tutto sul populismo chavista, che non vive nel vuoto pneumatico bensì nel mondo e quello circostante gli è ostile. Gli Stati Uniti lo isolano con un embargo severo quanto quelli contro Cuba e Iran. Che il paese fosse prima un Eldorado è una vera e propria falsità storica. Il chavismo è un effetto perverso, non la causa originaria della catastrofe che negli ultimi anni ha portato quasi 4 milioni di venezuelani ad espatriare temporaneamente o in via definitiva. Dittatori crudeli e presidenti corrotti hanno governato gran parte del secolo scorso. Il periodo democratico è cominciato solo nel 1959 con l’elezione di Romolo Betancourt (Acciòn Democratica), un socialdemocratico ricordato giustamente come padre della patria legale e legittima. Sentimento che tuttavia non gli ha risparmiato il malumore della classe media, alimentato da burocratizzazione e corruzione dei governi pur eletti nelle urne.

La minaccia della rottura istituzionale è sempre stata latente. Hugo Chavez esordisce come golpista nel 1992 per sloggiare da Palacio Miraflores un discreditato seguace di Betancourt, Carlos Andrés Perez; ma anticipa troppo i tempi e finisce in carcere. Cosi come li sbaglia l’opposizione al suo regime 10 anni più tardi, riuscendo a chiudere Chavez nel forte San Carlo; ma non a impedire che fosse liberato dall’intervento dei paracadutisti e dalla pressione del popolo delle periferie sceso massicciamente in piazza in suo nome. L’imprenditore e politico Pedro Carmona, capo della Confindustria, si era intanto fatto nominare presidente della Repubblica. Deve rinunciare precipitosamente e darsi alla fuga, cercando scampo presso l’arcivescovo e l’ambasciata degli Stati Uniti, tutt’altro che all’oscuro della congiura. Dall’interminabile dittatura latifondista di Juan Vicente Gomez (1908-1935) al fascismo di Marcos Perez Gimenez (1948-1958), salvo brevi e ibride parentesi, il potere è stato determinato nei labirinti delle caserme.
Nei paesi avanzati, non senza sommovimenti violenti, guerre e rivoluzioni, il pensiero moderno ha interagito con l’industrializzazione e l’urbanesimo, promuovendo l’integrazione delle masse contadine e operaie nei nuovi processi di produzione che con il tempo hanno portato alla creazione delle istituzioni democratiche. In Venezuela, com’è accaduto ad altri paesi ricchi di materie prime e relativamente periferici, il petrolio in virtù del suo gigantesco valore aggiunto ha surrogato uno sviluppo più ampio ed equilibrato, più sano. Ha catalizzato e assorbito non solo quasi tutte le limitate risorse umane e finanziarie del paese, ma anche il suo immaginario. Per un insieme di ulteriori fattori storico-economici, la monocultura petrolifera è stata incapace di favorire l’educazione e trasformare pienamente le energie e le conoscenze del grosso della popolazione in attività produttive. Ha di fatto portato fiumi di dollari, ma non minore emarginazione.
Il paradosso è solo apparente. In un contesto nazionale complessivamente arretrato, un’attività settorialmente molto avanzata dal punto di vista tecnico e così importante da quello economico richiede e ottiene la massima concentrazione d’investimenti. Al tempo stesso, la sua flessibilità in termini di dislocazione geografica e sociale è minima: non può che crescere e organizzarsi dove sgorga la materia prima e impiegare solo il sapere professionale specializzato. Pertanto è anche strutturalmente limitata come fonte occupazionale. Producendo inoltre una merce destinata massimamente all’esportazione per via marittima, è costretta a restare sulla costa. Tanto più che vari e intuibili motivi di sicurezza richiedono di isolarla ulteriormente per proteggerla da rischi esterni e delimitare le zone soggette alle contaminazioni dei liquami e della chimica che ne accompagnano le varie fasi produttive. Con il risultato di accentuare gli squilibri territoriali complessivi.
Tanto denaro è inoltre motivo di forti tentazioni, come s’intuisce. E non è facile trovare chi ha saputo resistervi, né nell’alta burocrazia della compagnia statale che gestisce il petrolio, la PDVSA (Petroleo de Venezuela SpA), uno stato nello stato, né nelle grandi compagnie petrolifere internazionali che ricevono concessioni e appalti, né nella politica. Un caso è esemplare: nel bipartitismo imperfetto che tra il 1960 e il 1993 s’instaura tra la socialdemocratica Accion Democratica del benemerito Romulo Betancourt e i socialcristiani del Copei (Comitè de Organizaciòn Politico-Electoral Independiente), due partiti sostanzialmente di centro, nel 1974 viene eletto presidente della Repubblica Carlos Andrès Perez, di AD. Il prestigio di entrambi i partiti, e con essi quello del sistema democratico-elettorale, con gli anni appare fortemente deteriorato.
La crisi petrolifera del 1973 ha fatto impennare i prezzi internazionali del petrolio e in Venezuela è tutta una festa milionaria. Le nazionalizzazioni di gas e petrolio che Perez completa in favore di PDVSA, però, scatenano raffiche di scandali per l’evidente enormità degli indennizzi concessi ai privati. Suscitano aperte e forti polemiche anche i rinnovi dei contratti di terzerizzazione dei servizi e i nuovi appalti. Mentre di questo favoloso e insperato tesoro alla massa dei venezuelani arrivano appena le briciole. In questa febbre dell’oro nero, l’economia scivola verso un indebitamento crescente. Perez completa il mandato in grande difficoltà.
Ciò nonostante dieci anni dopo, con il paese ormai in piena turbolenza, viene rieletto e va subito incontro alla tragedia del Caracazo, l’insurrezione della capitale venezuelana contro la severissima austerità imposta dal FMI (Fondo Monetario Internazionale): la repressione fa 400 morti. Ma lo stile di governo non cambia. Gli scandali continuano. Stavolta, malgrado la sua straordinaria abilità politica, la prima spada di Accion Democratica non ce la fa a completare il mandato. Nello scandalo del permanente conflitto d’interessi vengono anzi coinvolte anche moglie e segretaria personale (dalla quale ultima ha intanto avuto due figli). Chavez è ancora prigioniero in fortezza quando, non riuscendo a spiegare al Congresso una spesa segreta milionaria, Perez viene privato dell’immunità e va in carcere.
Oggi, dopo un quarto di secolo, il Venezuela è più che mai appeso a un filo. Maduro si è fatto rieleggere da un voto segnato da un forte astensionismo e non del tutto trasparente, ma neppure apertamente nullo. L’opposizione gli nega ogni validità e ha usato la maggioranza di cui dispone al Congresso per proclamarne il presidente, Juan Guaidò, capo provvisorio dello stato. Da Washington, Donald Trump lo incoraggia apertamente e minaccia un intervento militare diretto. Seguito senza remore dai maggiori paesi latinoamericani a eccezione del Messico, e con ben minore slancio dall’Unione Europea. I tentativi di mediazione, con il Vaticano in testa, corrono contro il tempo. Quasi come in una metafora di un nietzschiano eterno ritorno, dagli Stati Uniti dove è andato a rifugiarsi Carlos Andres Perez è in prima fila tra quanti adesso vogliono la cacciata di Nicolas Maduro.